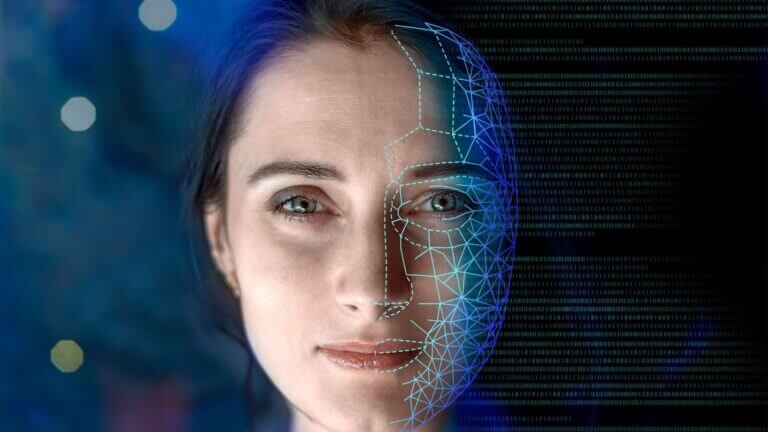Una delle principali sfide della Missione 6 (Salute) del PNRR è quella relativa alla Componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale a cui sono destinati 7 miliardi (su un totale di 15,63 miliardi di euro) che prevedeva la riforma: Servizi sanitari di prossimità, strutture e standard per l’assistenza sul territorio.
PNRR
Assistenza sanitaria territoriale: a che punto siamo col DM 77?
Un Servizio sanitario nazionale che mira ad essere più equo e sostenibile è uno degli obiettivi del PNRR da attuare anche mediante l’utilizzo della telemedicina, in linea con le più virtuose prassi europee
Cefriel – Esperta in progettazione e gestione progetti di sanità digitale
Regione Lombardia Direzione istruzione formazione lavoro – Componente direttivo Aisdet

PNRR
Assistenza sanitaria territoriale: a che punto siamo col DM 77?
Un Servizio sanitario nazionale che mira ad essere più equo e sostenibile è uno degli obiettivi del PNRR da attuare anche medinte l’utilizzo della telemedicina, in linea con le più virtuose prassi europee
Cefriel – Esperta in progettazione e gestione progetti di sanità digitale
Direttore Generale Università degli Studi di Brescia – componente direttivo AiSDeT
Una delle principali sfide della Missione 6 (Salute) del PNRR è quella relativa alla Componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale a cui sono destinati 7 miliardi (su un totale di 15,63 miliardi di euro) che prevedeva la riforma: Servizi sanitari di prossimità, strutture e standard per l’assistenza sul territorio.
La riforma si è realizzata con la definizione degli standard organizzativi e tecnologici omogenei per l’assistenza territoriale e le strutture ad essa deputate descritta nel DM n. 77 del 23 maggio 2022: “modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, pubblicato sulla GU n.144 del 22.6.2022.
Su tale tema, abbiamo già scritto a fine 2022[1], proviamo ora a fare il punto.
Indice degli argomenti
Sanità territoriale: il rapporto della Corte dei conti
Nel recente rapporto sulla finanza pubblica della Corte dei conti si legge che “dei 15,6 miliardi destinati al finanziamento della Missione 6 “Salute” dal PNRR, 11,2 miliardi sono stati ripartiti tra le regioni in funzione della realizzazione di misure localizzate sul territorio. Si tratta del 72 per cento del plafond destinato alla Missione e che interessa 12 investimenti rispetto ai 15 totali programmati. Nello specifico, risultano ripartite l’84 per cento delle risorse destinate alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”. [2]
Le risorse sono state ripartite sulla scorta delle programmazioni regionali e lo strumento attraverso il quale si concretizza il PNRR è il CIS – Contratto Istituzionale di Sviluppo – che proviamo ad “indagare” con riferimento al alcune regioni.
“Dei 15 investimenti del PNRR non risultano ripartite le seguenti misure: M6C1I1.2.3, “Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici”, la misura M6C2I2.1 “Valorizzazione, potenziamento della ricerca biomedica del SSN”, M6C2I2.2.C “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale”, M6C2I2.2.D “Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica”, ci dice il rapporto della Corte dei Conti.
I Contratti Istituzionali di Sviluppo
Lo strumento utilizzato per l’attuazione del PNNR è il CIS Contratto istituzionale di Sviluppo, il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione del programma degli interventi previsti, nel rispetto delle tempistiche per il conseguimento dei connessi milestone e target, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026 per gli interventi del PNRR, e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS
I Contratti Istituzionali di Sviluppo sono stati formalizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l’attuazione dei progetti relativi alla Missione 6 Componente 1 e 2 del PNRR. Tutti i 21 CIS sono stati sottoscritti tra il Ministero della Salute e ciascuna Regione e Provincia Autonoma a fine maggio 2022, in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal PNRR.
I CIS sono tutti visibili sul sito del Ministero della Salute[3], ed ora è disponibile un’analisi comparativa e una scheda di sintesi di questi strumenti di programmazione e investimento realizzata dall’Ufficio Studi della Camera dei Deputati.[4]
Il documento citato fornisce approfondimenti aggiornati, sia sugli investimenti e sub investimenti previsti e sulla loro assegnazione e riparto relativamente alla Missione 6, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, nonché sui diversi contenuti e standard previsti dal DM77.
Le Case della Comunità
Se guardiamo alle Case della Comunità (CdC), oltre ad indicare il target UE, indicato nel PNRR, pari a complessive 1350 CdC, si evidenzia che tale numero è stato incrementato perché nei CIS regionali complessivamente sono previste 1430 CdC, con un incremento quindi di quasi il 6%.
Il dettaglio è fornito per ogni regione per cui sono indicate anche quante CdC saranno hub e quante spoke, quante da ristrutturare e quante da edificare, nonché, con ulteriore tabella la differenza fra quante previste dal CIS e quante erano attive ad una mappatura del 2020 effettuata sempre dall’Ufficio Studi, come evidenziato nelle tabelle seguenti.
Ospedali di Comunità e Centrali Operative regionali
Tali interessanti e utili confronti di sintesi nazionale sono stati attuati anche per gli Ospedali di Comunità (OdC) e per le Centrali Operative regionali (COT). Per le COT ad esempio a fronte delle 600 COT iniziali relative all’intero territorio i CIS ne hanno aumentato il numero a 611, di cui 448 utilizzano spazi già esistenti, mentre 163 sono da edificare, e 59 di queste nuove COT sono in Lazio.


Fonte: Servizio Studi Affari Sociali, Camera dei deputati, n°23, 20 marzo 2023
Sempre per sottolineare la complessità attuativa del DM77 basta ricordare l’aspetto relativo al fabbisogno di personale che viene ben riepilogato nel documento citato dell’Ufficio Studi con riferimento alle diverse figure presenti, alle carenze attuali e ai fabbisogni emergenti ed anche in questo caso ai complessi aspetti normativi come ad esempio quelli relativi all’approvazione il 10/9/2020 da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome[5] delle “Linee di indirizzo infermiere di famiglia/comunità Ex l. 17 luglio 2020 n. 77 ” che dispone l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità.
Linee di Indirizzo per i servizi di telemedicina
Come abbiamo visto, alcune risorse sono ancora da ripartire e fra queste vi sono quelle dedicate ai servizi di telemedicina per la gestione della cronicità.
Non è un caso. Infatti a fine dicembre è stato finalmente pubblicato sulla GU il Decreto del Ministro della Salute in concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale[6]del 30 settembre2022 che era già noto nei contenuti ma che ha certamente risentito come tempistica per la pubblicazione del cambio di governo[7].
Rimettiamo quindi sulla linea del tempo lo sviluppo della regolamentazione in materia di telemedicina, a partire dalle linee guida del 2014.
Accordo | Accordo | Accordo | Decreto | Regolamento * | Decreto ** | Decreto *** |
20/02/ 2014 Linee di indirizzo nazionali | 17/12/ 2020 Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina | 18/11/ 2021 Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie | GU 24.5.2022 n° 120 Decreto Ministero Salute 29/04/2022 Approvazione Linee guida organizzative contenenti «Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», | GU 22.6.2022 n° 144 DM n° 77 del 23.5.2022 «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» | GU 2.11.2022 n° 256 Decreto Ministero Salute 21/09/2022 “Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio” | GU 22.12.2022 n° 298 Decreto Ministero Salute 30/09/2022 “Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di Indirizzo per i Servizi di Telemedicina. |
A fine anno si sono concentrati due provvedimenti interessanti, il primo riferito ai requisiti funzionali e ai livelli di servizio (il DM 256) che, al di là del fatto di aver introdotto il concetto di linee guida – sembra essere una declinazione ulteriore, ma sempre dall’ampio perimetro, rispetto alle linee di indirizzo nazionali – ha certamente fatto un passo concreto verso la omogeneizzazione dei requisiti funzionali elaborati da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), come espressamente citato.
A ruota è seguito il decreto di fine dicembre 2022 strumento utile per le Regioni e le Province Autonome che devono presentare progetti e formulare un piano operativo per poter definire i propri fabbisogni e iniziative progettuali sui servizi di telemedicina (Allegato A) per i quali il PNNR prevede risorse per un miliardo di euro, ancora da ripartire.
L’Allegato B definisce i requisiti clinici dei servizi di telemedicina finanziabili, e fornisce indirizzi per l’elaborazione di progettualità regionali in riferimento a specifiche aree cliniche e bisogni di salute, aggiunge poi indicazioni di carattere clinico-assistenziale (popolazione di riferimento, modalità di erogazione della prestazione, professionisti coinvolti, finalità della prestazione e benefici attesi) su prestazioni minime di telemedicina suddivise per i target di pazienti individuati:
- Televisita
- Teleconsulto/Teleconsulenza
- Teleassistenza
- Telemonitoraggio/Telecontrollo per pazienti con diabete, con patologie respiratorie, patologie cardiologiche e per pazienti oncologici e pazienti neurologici.
Il testo elenca i documenti e la normativa di cui si è tenuto conto nella sua predisposizione e indica l’ulteriore normativa la cui coerenza è poi necessaria nella fase attuativa.
Prendiamo ad esempio il Telemonitoraggio/Telecontrollo nel paziente con patologie cardiologiche, come popolazione di riferimento, dove si parla di “scompenso cardiaco (SC), prima causa di ricovero in Italia e larga parte d’Europa”, segnalando due tipologie di pazienti di specifico interesse per questi servizi di telemonitoraggio/teleconsulto:
- pazienti GUCH (Grown-Up Congenital Heart) o ACH (Adult Congenital Heart); il cui costo di gestione per il SSN (in termini di risorse, organizzazione e personale) è proporzionatamente elevato sia in ospedale che in gestione domiciliare;
- pazienti portatori di pacemaker (PM) (+65mila/anno) che dovranno essere inseriti nel progetto in particolare quando coesista o subentri scompenso cardiaco. Con analoghe considerazioni per pazienti con dispositivi impiantabili.
Inoltre, in linea con le indicazioni di stratificazione dei pazienti (in base alla gravità e al bisogno di salute), si esemplifica una classificazione su tre livelli fino ai pazienti candidati al trapianto.
Fra le modalità di erogazione si indicano i possibili professionisti coinvolti, medici specialisti (cardiologo, internista, ecc.); professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietista, fisioterapista, ecc.); altri professionisti non sanitari (es. psicologo) e si fa riferimento al Centro Servizi che garantisce il funzionamento del sistema infrastrutturale di telemedicina. Analogamente per i parametri da monitorare e controllare, si portano esempi di quelli più frequentemente utilizzati in letteratura, indicando che “la copertura oraria del servizio potrà dipendere dal tipo di prestazione erogata e dovrà essere formalizzato e comunicato al paziente tramite informativa al momento dell’attivazione” e può raggiungere le 24 ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal medico curante, così come protocolli specifici dovranno essere indicati per la gestione degli allarmi e per il percorso di presa in carico.
I tempi e l’architettura del percorso intrapreso
Sulla base della normativa ricordata possiamo quindi ricapitolare e temporizzare il percorso necessario per l’attivazione a livello nazionale dei servizi minimi di telemedicina nel modo seguente.
E nella tabella di seguito è evidenziato il serrato percorso regolatorio[8] da maggio 2022.

Come evidenziato, fra gli adempimenti segnalati vi è la DGR N° XII/180 del 27/04/2023 con cui Regione Lombardia e Agenas sottoscrivono una convenzione e (Art.2) “instaurano un rapporto di collaborazione, mediante l’apporto delle rispettive competenze e risorse”, in attuazione di quanto dispone l’art. 1 “Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale” del D.M. 30 settembre 2022, “nell’interesse pubblico, tra loro comune, consistente nella messa a punto e nella diffusione sul territorio nazionale dei Servizi minimi di telemedicina in conformità agli obiettivi di salute pubblica sottesi alla Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3. del P.n.r.r.” Prendono atto che Agenas ha dato corso al processo di acquisizione dei piani operativi e dei fabbisogni di ciascuna Regione e Provincia autonoma per i Servizi minimi di telemedicina secondo il format che costituisce l’Allegato A del D.M. citato e che Regione Lombardia, in qualità di Regione capofila, opererà per la realizzazione delle attività finalizzate all’acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica. Segue un più preciso dettaglio dei rispettivi compiti e la precisazione che la durata della convenzione (Art.5) sarà sino al 31 dicembre 2026.
Si sta quindi operando per attuare l’architettura complessiva il cui quadro sintetico è fornito dalla figura seguente, di cui al D.M. 21/09/2022.

Le singole regioni/PA hanno nel frattempo approvato con atto programmatorio, il proprio Piano Operativo Regionale per i Servizi Minimi di Telemedicina, predisposto sulla base dell’Allegato A del DM del 30/9 e ridefinito a seguito della valutazione effettuata con Agenas. In tal senso si rinvia ai provvedimenti delle singole regioni, segnalando ad esempio quello della Regione Friuli Venezia Giulia – DGR n°168 del 3/2/2023 Piano operativo regionale progetti di telemedicina – o per Regione Lombardia la DGR n° XII/164 del 17/04/2023[9] che consentono di valutare l’impatto di una richiesta ministeriale analoga ma declinata in contesti territoriali diversi sia per tipo di autonomia sia per dimensione di popolazione coinvolta.
In ogni caso il livello di complessità presente nell’utilizzo di strumenti di telemedicina nell’ambito dell’assistenza territoriale è elevato e per comprenderlo occorre ricordare la normativa connessa all’assistenza territoriale inserita anche nella Missione 5 (“Inclusione e coesione”), ad esempio per la Componente 2 (“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”) a cui si riferiscono due progetti di Riforma indicati in due leggi delega rispettivamente una sulla disabilità[10] e una sulla persone anziane/non autosufficienza/[11] con decreti delegati da definire poi entro i primi sei mesi del 2024. In tale complessa riforma si parla ad esempio di livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e dell’integrazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI).
Infine, sempre dalla relazione della Corte dei Conti, evidenziamo che la ripartizione delle risorse della Missione 6 è ancora parziale, atteso che secondo le stime del Dipartimento per la Coesione Territoriale, le misure “territorializzabili” in questo settore ammontano a 14,2 miliardi. Per alcune misure, devono ancora essere pubblicati i bandi relativi ad annualità successiva al 2022/2023, mentre per altri interventi, la procedura amministrativa di assegnazione dei finanziamenti potrebbe non essere ancora giunta a conclusione.
Ad esempio, lo scorso 27 aprile 2023 è stato lanciato il secondo bando, emanato dal Ministero della Salute, per finanziare proposte progettuali di ricerca legate all’investimento “2.1 – Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN, del valore di oltre 310 milioni di euro, per potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),”.
Conclusioni
Innanzitutto bisogna ricordare che Il PNRR è un programma “performance-based” e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestones e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che, pertanto, il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province Autonome sono Soggetti Attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l’interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE).
Gli interventi previsti nella missione 6 non sono certo banali e, come dimostrato dal percorso fin qui fatto, sono state poste le basi per realizzare gli obiettivi nei tempi previsti.
Riteniamo di poter confermare due aspetti:
- la pandemia, prima, e il PNRR, poi, hanno portato ad un completamento del quadro regolatorio per l’utilizzo diffuso e a regime della telemedicina unitamente ad uno slancio verso la digitalizzazione di alcuni processi,
- l’auspicata omogeneizzazione dei servizi a livello nazionale e la garanzia della presenza effettiva di servizi territoriali, di fatto non si è concretizzata: il cuore della programmazione e dell’erogazione dei servizi territoriali non è stato codificato ed è lasciato alla libera interpretazione regionale ma ciò potrebbe non avere solo aspetti negativi se venisse comunque indirizzato con giuste motivazioni.
Vi sono almeno altre due riflessioni da fare: la prima relativa al tema degli investimenti indicati dalle regioni nei CIS, la seconda relativamente agli investimenti sulle risorse umane.
Quanto ai CIS, dagli stessi emergono differenti approcci da parte delle regioni e, soprattutto, differenti punti di partenza. È chiaro che in tutti i casi in cui nelle regioni erano già state attivate e regolamentate le c.d. “case della salute” si tratta di mettere mano ad una rete di strutture e di servizi già esistenti, obiettivo raggiungibile con una certa facilità. Nei casi in cui invece, sempre a livello regionale, si è di fronte ad una rete assistenziale più centrata sul livello ospedaliero e specialistico, il percorso realizzativo diventa certamente più arduo, in particolare se pensiamo all’implementazione dei servizi territoriali previsti nelle case di comunità, all’impatto sui cittadini, all’esigenza di salvaguardare positive esperienze. In tutti i casi comunque il sistema territoriale dovrà essere rivisto anche alla luce del contributo delle innovazioni intervenute sia a livello tecnologico sia a livello clinico affinché sia raggiunta un’effettiva ed efficace cura delle persone con un approccio ora definito con il concetto One Health, indicato anche nel PNRR.
L’altra riflessione riprende quanto già evidenziato, in merito alla ripartizione delle risorse: forse non è un caso che ancora non siano state ripartite quelle relative alla M6C2I2.2.C “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale”.
Il tema delle risorse umane e della loro disponibilità è un elemento cruciale, da più parti evidenziato. Vi è la necessità di formare e riqualificare gli operatori presenti ma vi è contestualmente una grande necessità di formare le figure professionali della sanità in un nuovo “modo” con attenzione alla multidisciplinarietà e con adeguati skill che consentano di lavorare, anche con il supporto del digitale, in modo integrato e sinergico in team multiprofessionali.
Forse un organismo terzo che analizzi i lavori in corso e le modalità attuative nelle diverse regioni, potrebbe essere di qualche utilità, anche per rendere consapevoli sia le regioni che le singole amministrazioni della loro collocazione non solo in termini di utilizzo delle risorse economiche.
Assistenza territoriale e telemedicina: l’applicazione del DM 77, pubblicato il 28.12.2022 ↑
CORTE DEI CONTI Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica Sezioni riunite in sede di controllo 2023 GLI INVESTIMENTI IN SANITÀ: TRA FONDI ORDINARI E PNRR Il Rapporto è stato elaborato con le informazioni disponibili al 12 maggio 2023 ed approvato nell’adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 17 maggio 2023. ↑
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3240 ↑
Camera dei deputati, XIX LEGISLATURA, I presidi dell’assistenza territoriale nella Missione 6 Salute del PNRR, n. 23, 20 marzo 2023, Documentazione e ricerche, SERVIZIO STUDI – Affari Sociali – pag.29 https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-17976/i-presidi-assistenza-territoriale-nella-missione-6-salute-del-pnrr.html ↑
http://www.regioni.it/newsletter/n-3909/del-17-09-2020/infermiere-di-famiglia-e-di-comunita-linee-di-indirizzo-21653/ ↑
GU 22.12.2022 n° 298 – Decreto Ministero Salute 30/09/2022 “Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di Indirizzo per i Servizi di Telemedicina”. ↑
Il governo Meloni, primo della XIX legislatura, è in carica dal 22 ottobre 2022. ↑
Con * i riferimenti alla normativa elencata nella figura precedente ↑
“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 1, SUB-INVESTIMENTO
1.2.3, INVESTIMENTO 1.2.3.2. – APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE PER I SERVIZI DI TELEMEDICINA” ↑
G.U n. 309 del 30 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge n. 227 del 22 dicembre 2021 Delega al Governo in materia di disabilità. Decreti delegati devono essere adottati dal Governo entro il 30 Giugno 2024. ↑
G.U. n. 76 del 30 marzo 2023 è stata pubblicata la Legge n.33 del 23 marzo 2023 023, Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Decreti delegati da adottarsi entro il primo trimestre 2024. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/30/23G00041/sg ↑
Continua a leggere questo articolo
Argomenti
Canali
EU Stories - La coesione innova l'Italia