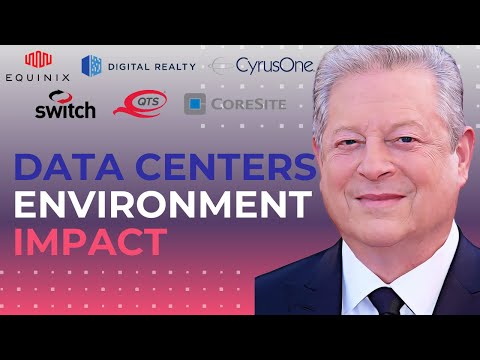Nel quadro della “transizione gemella” ecologica e digitale si sta ponendo sempre più attenzione agli impatti ambientali delle tecnologie digitali ed in particolare delle infrastrutture tecnologiche rappresentate dai datacenter.
Indice degli argomenti
Gli studi sul consumo energetico dei datacenter
L’Unione Europea ha avviato una serie di studi e messo a disposizione strumenti[1] per sostenere la transizione verso un cloud più “verde” e datacenter più sostenibili. Il riconoscimento degli impatti ambientali dei datacenter tiene conto della crescente domanda di servizi cloud legate al mercato consumer, business e della Pubblica Amministrazione. Una crescita che spinge all’ampliamento del numero dei datacenter, con implicazioni però sul fronte dell’energia consumata e degli impatti ambientali che si vengono a creare. Al 2022 a livello mondiale Statista riporta un numero pari ad oltre 6.300 datacenter per 15 paesi (fonte: Statista 2022), di cui circa 2.700 solo negli Stati Uniti, a seguire la Germania con 487, al terzo posto la Gran Bretagna con 456, mentre per l’Italia la stima è di 131 data center.
Gli studi sul consumo energetico dei datacenter sono sviluppati e si concentrano sul PUE Power Usage Effectiveness (PUE) come indicatore standard internazionale che misura il rapporto tra la quantità di energia usata complessivamente da un data center e la quantità di energia usata dalle apparecchiature IT. Più questo rapporto è vicino a 1, maggiore sarà l’efficienza del data center a sottolineare come la totalità dell’energia elettrica venga utilizzata per le attività core del datacenter, riducendo al minimo il consumo per il raffreddamento dell’infrastruttura. Secondo un’indagine Statista del 2021, i responsabili IT e dei data center hanno dichiarato un rapporto medio annuo di efficienza energetica (PUE) di 1,57 nel loro data center più grande, contro il 2,5 del corrispondente valore nel 2007. Risultati analoghi si riscontrano con un approfondimento sul fronte dei data center che abbiamo condotto a livello europeo. I datacenter che adottano tecnologia più recente (hyperscale) sono più efficienti rispetto agli altri data center, per effetto dell’ampio ricorso alla standardizzazione nella progettazione e dell’elevata frequenza di sostituzione delle apparecchiature con tecnologie energeticamente più efficienti.
Sebbene questi risultati siano incoraggianti e mettano in luce il forte impegno degli operatori sul fronte dell’efficienza, l’impronta ecologica di un Data Center non può essere valutata unicamente nella sua fase d’uso ovvero di consumo energetico. Per avere un’idea più precisa è necessario tenere in considerazione anche le fasi “a monte” del data center che sono riconducibili essenzialmente alla produzione di tutti quegli apparati (server, dischi rigidi, cavi di rete, switch, ecc.) necessari al suo funzionamento, e “a valle” ovvero a come viene gestito il fine vita di questi apparati. Questa necessità è tanto più urgente se si considera il fatto che i data center hanno la necessità di rinnovare server e dischi rigidi ogni 3-5 anni. In altri termini, è necessario pensare ad un cambio di passo nella valutazione dell’impatto ambientale passando da una valutazione puntuale basata su un indice di efficienza come il PUE ad una valutazione più ampia che tenga in considerazione quanto accade a monte e valle del data center.
Misurare l’impatto ambientale: lo studio LCA di un data center
Seguendo un approccio legato all’economia circolare, gli impatti di un data center sono connessi a quattro aspetti principali: 1) la costruzione e la predisposizione della struttura che ospita il data center, 2) la produzione e il trasporto degli apparati tecnologici necessari alla gestione dei dati (server, router, gruppi di continuità, ecc.), 3) l’operatività e l’uso di questo strumenti e 4) la gestione del fine vita (riutilizzo o smaltimento con eventuale recupero dei materiali). Di questi quattro elementi, soltanto tre sono sotto il diretto controllo dei gestori dei data center: la costruzione della struttura, l’uso e il fine vita. La produzione e il trasporto degli apparati tecnologici dipendono infatti dai grandi operatori del settore dell’Information Technology (produttori di chip, server, dischi rigidi, ecc.). Al massimo i gestori dei data center potrebbero influenzare in modo indiretto i produttori andando a scegliere quei prodotti che hanno un impatto ambientale inferiore.
Per riuscire ad avere una rappresentazione più completa degli impatti di un data center si può ricorrere alla metodologia Life Cycle Assessment (LCA), che consente di quantificare i carichi energetici e gli impatti ambientali generati durante l’intero ciclo di vita – dall’acquisizione delle materie prime al fine vita – di un qualsiasi prodotto, processo o attività. Per quanto attiene ad un data center, l’LCA parte dall’analisi delle materie prime utilizzate e dei relativi processi di estrazione, a cui fanno seguito l’analisi dei processi di produzione dei componenti del data center e la valutazione delle fasi di utilizzo e fine-vita della struttura. Da un lato vengono valutate le risorse utilizzate (materiali, energia, acqua) e dall’altro vengono stimati gli impatti generati dalle emissioni in aria, in acqua e nel suolo prodotte lungo il ciclo di vita del data center.
Non sono presenti, a livello internazionale, molti studi riguardanti l’LCA applicata ai data center (nella letteratura scientifica, si rilevano i lavori di Whitehead[2] e di Shah et al.[3]); tale carenza può probabilmente essere spiegata dalla complessità del reperimento delle informazioni utili alla misurazione delle risorse coinvolte e alla quantificazione dei conseguenti impatti. Nell’ambito del progetto sulla sostenibilità delle infrastrutture digitali realizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” e finanziato da Università di Padova e Regione del Veneto – Direzione ICT e Agenda Digitale, è stato condotto uno studio di applicazione della metodologia LCA a un data center. La ricerca, durata circa sei mesi nel corso del 2022, era finalizzata a elaborare una prima stima degli impatti ambientali di un datacenter, oltre a fornire indicazioni più generali in merito alla fattibilità e replicabilità di tali studi e alle criticità e implicazioni sul fronte gestionale e di indirizzo istituzionale. Caso-studio dell’analisi è stato il VSIX (Centro di Ateneo per la Connettività e i Servizi al territorio dell’Università di Padova) di Padova, il quale costituisce l’Internet Exchange Point (IXP) del Nordest Italia, oltre a gestire un data center (servizi di colocation).
Lo studio si è concentrato sulle fasi di realizzazione del data center – estrazione dei materiali, produzione e trasporto dei vari componenti – e di utilizzo dell’infrastruttura stessa. Per la valutazione della fase di utilizzo sono stati in particolare rilevati i consumi energetici e sono stati considerati i diversi tassi di sostituzione delle apparecchiature componenti il VSIX. Non è invece stato analizzato il fine-vita del data center a causa della difficoltà di ottenere una stima affidabile, considerata la scarsità di dati disponibili relativi allo smaltimento delle tecnologie IT. Analogamente, non è stato possibile rilevare dati sulle percentuali di materiali riciclati; pertanto le risorse utilizzate per la produzione dei componenti sono ipotizzate derivare interamente da materie prime vergini. Anche se è vero che gli studi esistenti attribuiscono al fine-vita dei sistemi IT un impatto limitato rispetto all’intero ciclo di vita, tale aspetto acquisirà in futuro sempre più rilevanza, considerate la crescita del settore e il conseguente consumo ingente di materiali. Studi futuri richiederanno quindi ulteriori approfondimenti a riguardo.
Per l’analisi LCA del caso-studio VSIX è stato adottato, tra i vari metodi di valutazione degli impatti disponibili, il CML-IA baseline / EU25. Secondo questo metodo, sono stati stimati gli impatti relativi a 11 diverse tipologie, tra cui il consumo di risorse minerarie e fossili, l’impatto sul clima, l’effetto tossico sulla salute umana e sugli ambienti acquatici e terrestri. Ciò ha permesso quindi una valutazione degli effetti della realizzazione e gestione di un datacenter sulla salute umana, sulla qualità degli ecosistemi e sul consumo delle risorse naturali. Nello studio è stata data particolare attenzione agli impatti in termini di CO2 emessa e quindi relativi al riscaldamento globale.
I risultati: attenzione agli acquisti e criticità delle tecnologie più recenti
Lo studio LCA mostra come il 61% delle emissioni totali (tonnellate di CO2 equivalente) sia attribuibile alla fase di realizzazione del datacenter, mentre il 39% è dovuto al suo funzionamento (consumo di energia). Questo primo dato è importante per sottolineare come le implicazioni ambientali di un datacenter sono molto più ampie e riguardano una sfera di attori e un contesto geografico molto più esteso ed articolato di quanto ci si possa aspettare.
Andando a guardare nel dettaglio la fase realizzativa del datacenter e quindi la varietà delle tipologie di sistemi tecnologici considerati, fatto 100 il totale delle emissioni di CO2 equivalente, il 66% di queste è riferibile alla produzione degli apparati di rete e il 27% alla produzione di server e storage. Le restanti emissioni (7% in totale) sono associate ad altri sistemi IT e ai sistemi di alimentazione (UPS, gruppo elettrogeno, cavi, …) e di raffreddamento. L’impatto elevato dei sistemi IT (complessivamente 93% delle emissioni di realizzazione) è legato principalmente all’elevato contenuto di materiali preziosi e/o rari (es. oro, argento, terre rare, …), alla quantità di risorse (energia, acqua, agenti chimici, …) impiegate nei processi produttivi e al considerevole tasso medio di rinnovo di tali apparecchiature (circa 5 anni).
Complessivamente, possiamo stimare in circa 86 tonnellate di CO2 equivalente all’anno l’impatto climatico del VSIX (costruzione e funzionamento). Questo valore equivale alle emissioni prodotte da un’auto che viaggia da Padova a Roma – andata e ritorno – ogni giorno dell’anno (~400.000 km). Questi impatti sono relativamente contenuti in quanto il VSIX beneficia delle politiche di approvvigionamento energetico dell’Università di Padova, che effettua unicamente acquisti di energia da fonti rinnovabili[4]. Se tuttavia ipotizzassimo che il VSIX utilizzi elettricità proveniente dal mix energetico nazionale, il suo impatto climatico aumenterebbe di 5 volte. In questo caso, la quota prevalente delle emissioni sarebbe legata ai consumi energetici (87,4%), mentre solo il 12,6% sarebbe attribuibile alla realizzazione. È inoltre da considerare che il VSIX è un datacenter di piccole dimensioni se paragonato ad altri grandi operatori a livello nazionale ed internazionale, i quali possono arrivare a consumare oltre a 500 volte più del VSIX. Ciò ci può dare un’idea indicativa di quanto possano essere enormi gli impatti ambientali di tali strutture…
Lo studio ha messo in evidenza anche altri aspetti importanti relativi alla produzione di sistemi complessi quali quelli delle tecnologie IT. In particolare, dal confronto di due tipologie di dischi di archiviazione dati – HHD e SSD – è emerso come, a parità di capacità di storage e considerati sia produzione che funzionamento, l’impatto climatico della tecnologia più recente SSD è circa il doppio rispetto a un HHD. A condurre a questo risultato è principalmente l’impatto di produzione, particolarmente elevato per i dischi SSD; questa tecnologia basa infatti il suo funzionamento su circuiti integrati, la cui produzione richiede enormi consumi di risorse, in particolare energia ed acqua.
Alcune indicazioni per il futuro (prossimo) per la sostenibilità dei datacenter
Lo studio LCA ha consentito di comprendere meglio i potenziali effetti sull’ambiente di un data center, riuscendo a fornire indicazioni più precise sui driver di tali impatti e sulla reale sfera di intervento da parte dei gestori dei data center. Poiché una quota importante della CO2 equivalente prodotta è connessa alle fasi di estrazione, produzione, approvvigionamento e realizzazione dei data center, diventa importante prestare attenzione alle scelte sul fronte degli acquisti – anche in termini di Acquisti Verdi (green public procurement – GPP). Questo può richiedere per contro una maggiore necessità o opportunità di trasparenza informativa da parte dei produttori sul fronte delle risorse impiegate, all’insegna di una più estesa sostenibilità ambientale della catena del valore. Allo stesso tempo lo studio mostra il diverso impatto di una fornitura di energia da fonti rinnovabili piuttosto che legata ad un mix energetico tradizionale.
Inoltre, la possibilità di ampliare anche al fine vita l’analisi LCA potrebbe consentire di migliorare l’impatto dei datacenter dal punto di vista ambientale (e sociale), attraverso una più attenta strategia di riuso, recupero e/o riciclo orientata all’economia circolare. In forma più estesa si potrebbe arrivare a progettare già in chiave di circolarità (circular by design) pensando al fine vita. Il diverso e controintuitivo risultato relativo alle tecnologie per lo storage dei dati – ove le tecnologie più recenti impattano più di quelle più vecchie – richiede di poter gestire il trade-off tra prestazioni tecnologiche e impatti ambientali, aumentando però anche le opzioni per i gestori dei datacenter. Gli operatori potrebbero costruire un mix di apparati per esigenze diverse, in grado di abbassare l’impatto complessivo delle emissioni.
Note
- https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/green-cloud ↑
- https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11367-014-0838-7.pdf ↑
- https://asmedigitalcollection.asme.org/electronicpackaging/article/133/3/031005/455215/Evaluating-Life-Cycle-Environmental-Impact-of-Data e https://ieeexplore.ieee.org/document/6227975 ↑
- https://www.sostenibile.unipd.it ↑